Spesso le vicende della vita ci portano a fare degli incontri che, se la storia…
IN AMARITUDINE – di Tommaso Mazzoni
È davvero con tanta amarezza, credetemi, che mi accingo a scrivere quanto ho deciso, qui, di riportare.
di Tommaso Mazzoni
Ma, prima ancora di tentare di raccontare le ragioni della mia forte emozione(1) provata ieri durante la conferenza di un ex deportato nei campi di sterminio nazisti, vi informo anche che, altrove, in taluna di queste mie pagine(2), vi si possono trovare testimonianze anche di un altro ex deportato della mia Città, ossia Saffo Morelli; fu da me raccolta nel corso di un pomeriggio dell’aprile del 1999, dopo che gli avevo telefonato presso il suo domicilio. Mi raccontò così, a tratti accoratamente, una larga parte delle sue peripezie.
Il caro Saffo Morelli mi fissò cortesemente un incontro per parlarmi, come da me chiesto, allo scopo di farmi conoscere, con esattezza, tanti particolari riguardo agli infami atteggiamenti e alle crudeltà perpetrate nel corso delle folli deportazioni nazi-fasciste(3), dalle quali pochi, effettivamente pochi tornarono alle loro case, dai loro cari.
Ho ripreso oggi la penna in mano, per così dire, perché le due esperienze, pur avendo il comune denominatore di una medesima ignominia, si riferiscono a episodi diversi. Ma entrambi evocano scenari tali da non riuscire a raccapezzarsi come sia stato possibile, a uomini fatti come noi e che avrebbero dovuto essere dotati di affine sensibilità, di arrivare a tanto…
Riporterò quindi anche ulteriori episodi, relativi, fra i tanti, a quest’altro deportato, il quale ha sofferto pure lui le pene di un inferno indicibile: sevizie e infami comportamenti, concepiti da uomini come noi, dicevo, ma che -, per, e sotto la criminale follia dei due capi del fascismo e del nazismo -, hanno avuto verso loro simili atteggiamenti crudeli a malvagi.
Dai libri di storia ci possiamo informare su molte cose, quali ad esempio sulle leggi razziali, sul numero seppure approssimativo dei deportati, su quando e dove sono avvenuti certi fatti; su quanti morti e feriti, sempre secondo taluni calcoli, si sono avuti nel corso della seconda guerra mondiale, e così dicendo. Perciò, pure se potrò sicuramente aggiungere qualche necessario dettaglio, ho ritenuto di non indugiare eccessivamente su un tal genere di descrizioni: ci sono i libri di storia, per questo, come dicevo. Ho preferito invece riportare notizie di prima mano, ossia fatti reali, così come si sono esattamente svolti, raccontati dalla viva voce di chi ha avuto la malasorte di ritrovarsi in determinate situazioni, oltretutto dove non poteva essere imboccata alcuna via di scampo.
Le notizie e i fatti descritti dagli storici, quindi, non li ho voluti, qui, prendere in considerazione, pur nella loro indubbia importanza, privilegiando invece particolari, a volte anche assai scabrosi, che non possono apparire nelle cronistorie ufficiali, unicamente perché troppo personali; talora addirittura intimi.
Certe volte, in chi racconta, si avverte che ne prova, con ragione, un qual certo ritegno e forte imbarazzo. Tuttavia descrive, svela, denuncia i soprusi e le sevizie subìte; prendendo il coraggio a quattro mani e mostrando a noi, quasi increduli per tanta barbarie, ciò che è realmente avvenuto, affinché, mettendoci così in guardia, siffatti oltraggi non abbiano più ripetersi.
Hanno avuto luogo fatti assai oscuri, volutamente esclusi dalla conoscenza di un’opinione pubblica che avrebbe dovuto essere in ogni caso parimenti informata: alludo ora agli altrettanto delitti che sono stati perpetrati, seppure con modalità diverse, con spietata ferocia e crudeltà, ossia gli episodi che alla fine sono venuti a galla, seppure non completamente, attraverso le descrizioni dei fatti conosciuti sotto il nome di “foibe” (o “fojbe”). Riporterò un po’ più avanti, tali eventi. Purtroppo sono stati fatti conoscere dopo diverse decine di anni, quasi che i morti potessero avere una classificazione: infatti, di tanti casi si è potuto venire subito a conoscenza, mentre di altri fatti, parimenti brutali, nessuno ne ha mai parlato.
Già. Tacere. Altra ignominiosa infamia.
Desidero informarvi che un’ampia documentazione generale, ovvero che non riguarda soltanto le foibe, l’ho trovata in un’accurata pubblicazione(4), voluta e realizzata dal Comune di Castelfranco di Sotto in Provincia di Pisa. Essa reca giustappunto il titolo «Per non dimenticare(5)», ed è stata pubblicata grazie alla volontà degli Amministratori di quel Comune, allo scopo di ulteriormente sottolineare il valore della “Settimana della Memoria e del Ricordo”.
Dovrò fare tuttavia un’eccezione, al riguardo della regola che m’ero data, ossia quella di voler ricorrere soltanto a testimonianze dirette: per un preciso, specificato caso, ho dovuto per forza attenermi ad accadimenti riportati da testimonianze non dirette, seppure di indubbia veridicità. Riguarda la triste sorte degli “infoibati” (questo è il tragico, pressappochista verbo comunemente usato in molti casi), i quali, poveretti, non hanno potuto, né potranno mai testimoniare, perché uccisi per averne gettato i loro corpi – talvolta vivi – in pozzi carsici stretti e bui, dette gole. Atti di cui riporterò un’analisi dei fatti certamente incompleta, e tuttavia probante. Atti pazzeschi!
Il volere ricordare vale soprattutto per le nuove generazioni, ché altrimenti non potrebbero rendersi conto del tutto di cosa, nel corso del secolo appena trascorso, è stato capace questo civile ed evoluto uomo, semmai quegli individui responsabili di sì enormi misfatti ci sia dato di poterli chiamare uomini.
Per quel che mi sarà possibile, tenterò di dare un certo assetto a queste mie descrizioni. Comincio, perciò, col riportare, qui di seguito, le parole di Mauro Betti, uno degli ex deportati nei campi di sterminio. Ho trascritto, naturalmente dopo averne ottenuto il suo esplicito consenso, seppure verbale, le sue esatte frasi che ho tratto da un suo libriccino (piccolo per mole, ma grande e denso di contenuti), significativamente intitolato «Buio e Luce».
Tuttavia avevo seguìto, come più sopra anticipato, anche l’ampia e chiara esposizione degli accadimenti attraverso la voce stessa di Mauro Betti. A tale libro, peraltro, ha anche dato un appropriato sottotitolo, ossia “L’Oscurità trascorsa illumini i posteri”(6).
Per aver attraversato, seppure da bambino e giovinetto, e per aver subìto anch’io personalmente il dramma di quella medesima guerra, in queste mie pagine ho inteso di riportare, giustappunto per i posteri, quel che sono riuscito così a raccogliere. Cosa che anch’io avverto altrettanto doverosa.
Nutro perciò la speranza che non vengano spazzate via troppo presto, tali preziose testimonianze, e che possano essere lette e tramandate ancora da persone volenterose come coloro che ho qui ricordato, affinché le future generazioni possano ulteriormente rendersi conto a cosa possa condurre una dittatura e, se non con la volontà e il sacrificio di altri – è questo il caso che riguarda il nostro Paese -, come sia difficoltoso riottenere la libertà.
Con chi facilmente fucila o impicca, o con chi prende a calci per un nonnulla o addirittura senza alcun motivo, inermi cittadini, niente – e intendo sottolineare “niente” – l’uomo così soggiogato può fare in difesa sua, dei propri cari o del proprio Paese!
Occorre perciò pensarci prima; e sorvegliare. Sempre prima. Perché quando il patatrac è avvenuto, sicuramente seguono altri sfaceli, l’uno dietro l’altro, fino al momento dell’auspicabile liberazione, ove questa possa aver sempre luogo; ma non è detto.
Teniamolo presente, perciò, tale particolare, teniamolo bene in mente. E, come ho detto poco fa, vigiliamo “prima”, che è un’espressione anche ridondante, ma ciò lo affermo solo perché dopo – e sottolineo ancora con tutta la mia forza “dopo” – potrebbe essere troppo tardi.
Mauro Betti ha pubblicato il suo prezioso libro nell’anno 1998, a Cècina, in Provincia di Livorno. Ne trarrò, come dicevo, parecchie sue frasi, che scrupolosamente trascriverò tra virgolette.
Nel libro vi figura anche una particolareggiata mappa degli spostamenti fatti forzatamente percorrere allo stesso Betti: Zagabria (luogo di deportazione), Gross Rosen, Breslavia, Buchenwald, Flossenbürg (luogo della fuga), Weiden (luogo della liberazione).
Betti ha anche tracciato su di una cartina geografica il tragitto di ritorno fino al luogo dove allora viveva, e dove l’attendevano i suoi familiari, ossia Castagneto Carducci, in Provincia di Livorno.
Oltre che per la toccante e ricca conferenza tenutasi a Capraia Fiorentina sabato 9 Febbraio 2008 in virtù della iniziativa del Comune di Capraia e Limite, debbo davvero ringraziare l’Autore per il dono che mi ha fatto, di questo suo libro, e per la dedica che ha voluto apporvi(7).
I capoversi del racconto di Mauro Betti, così come riportati, non avrebbero dovuto esser “scelti”, come purtroppo sono stato costretto a fare per comprensibili ragioni. Ho dovuto sacrificare anche taluni capitoli, e mi dispiace, ma un intero libro non potrei certo inserirlo in quest’unico capitolo. Per tutto ciò, quindi, ancor prima di cominciare, chiedo venia al suo Autore e a voi, che vi accingete a leggere il suo tormento e a dare nuova energia alla sua invocazione.
Queste che riporto qui di seguito sono perciò, una per una, le sue esatte parole:
– «Era certamente il mese di settembre del 1944: il treno, composto da una trentina di carri bestiame, attendeva il suo carico umano sul primo binario della stazione di Zagabria. Il sole era ancora alto e noi eravamo in molti, tutti croati o sloveni però, solo io ero italiano, ma tutti ex partigiani o sospetti. Molti parlavano l’italiano, quindi avevo modo di conversare con loro.
Provenivamo dal carcere di Zagabria, dove io, dopo due mesi di detenzione, avevo subito un processo sommario ed ero stato condannato ai lavori forzati nelle fabbriche in Germania, avendo rifiutato, in alternativa, di rientrare in Italia per arruolarmi nell’esercito della neo-costituita Repubblica Sociale Italiana. […]».
«Col cuore ero sempre vicino ai miei cari: erano trascorsi oltre quattro anni dalla mia partenza (aprile 1940) e non avevo mai avuto una licenza, non solo, ma dal momento della capitolazione, settembre 1943, non avevo potuto dare più notizie di me. La mia speranza era quella di potergliele inviare dalla mia nuova destinazione in Germania. […]».
«In territorio austriaco la sorveglianza diventò ben più severa. A Vienna il treno sostò per molte ore. Io chiesi di poter fare i miei bisogni corporali, la guardia SS mi fece scendere dal vagone e senza farmi allontanare estrasse la pistola, inserì la pallottola in canna e la puntò su di me accompagnandola con parole in un tedesco sgarbato e minaccioso, che io non capivo, dette con voce alterata. Feci quello che dovevo fare velocemente con la pistola sempre puntata, poi rientrai nel vagone. Quel comportamento mi turbò e nacquero in me molti interrogativi a cui non riuscivo a dare una risposta.
Partendo da Vienna viaggiammo ancora per molto tempo, non ricordo quanto: la nostra destinazione nessuno la conosceva.
In un scalo ferroviario di una stazione sconosciuta ci fecero scendere tutti, ci incolonnarono e dopo una lunga marcia giungemmo ad un grosso cancello con al fianco una piccola costruzione, il corpo di guardia delle “SS”. Sopra al cancello una grossa scritta: “Gross Rosen”, era il nome del campo e la nostra prima destinazione. […]».
“Varcammo il cancello e davanti al corpo di guardia con dentro le “SS” ebbi il benvenuto: un calcio nel sedere mi sollevò da terra e poi frasi minacciose urlate in tedesco senza che io capissi il perché. Un croato vicino a me mi sussurrò: – Togliti il cappello. Non indugiai e capii che “Muzze ab!” significava togliersi il cappello. A parte il calcio, la prima impressione entrando nel campo fu ottima: al di là del cancello davanti a noi c’era una strada dritta, ordinata, pulita, perfetta. Il terreno era scosceso e alla sinistra vidi una serie di baracche in legno, ordinate, non le contai ma erano molte; dopo imparai che si chiamavano “block”. Notai con meraviglia che ogni baracca era separata dalle altre con un filo spinato. Sulla destra, più in alto, c’erano altre baracche, ma una mi colpì perché aveva un’alta ciminiera e mi fu detto che era il “crematorium”.
Tutto intorno al campo c’era una serie di recensioni di filo spinato, e fra l’una e l’altra un camminamento con grossi cani da guardia liberi. L’ordine più interno di filo spinato era percorso dalla corrente elettrica ad alta tensione; agli angoli della recinzione si ergevano lugubri torrette quadrate e nere, che si restringevano verso l’alto e con il tetto fortemente spiovente. Sotto il tetto, ben visibili, le sentinelle “SS”, sempre di guardia, pronte a sparare, e succedeva spesso, ai prigionieri se solo si avvicinavano al reticolato.
In fondo alla strada che io avevo davanti vidi un prigioniero che sulle prime mi suscitò una buona impressione: era un detenuto con una casacca a strisce verticali; avvicinandomi notai la testa rasata con una striscia larga quattro centimetri dalla fronte alla nuca che mostrava la cute.
Ero completamente disorientato, non mi stavo rendendo conto di quanto mi stava succedendo e non potevo arrivare a immaginare quale orribile sorte mi era toccata.
Ma non passò molto tempo perché me ne rendessi conto. Di lì a poco fummo introdotti in una baracca fra quelli addetti ai servizi e ci trovammo fra urli e calci. I calci li capii subito, ma il significato delle parolacce e degli urli lo imparai in seguito. Dentro questa baracca non c’erano più le sentinelle “SS”, ma altri prigionieri, anche loro vestiti a strisce, che però avevano in comune con le “SS” l’estrema malvagità (in seguito si vedrà che in realtà erano dei criminali). I maltrattamenti potevano essere compresi da parte delle “SS”, ma quello che non riuscivo ad accettare era che provenissero da un prigioniero come me, dentro al campo per lo stesso motivo per cui c’ero anch’io; presto seppi che si chiamavano “Kapó”. Le loro armi erano un bastone, o una frusta o un nerbo con i quali ci picchiavano senza alcun motivo.
Lì dentro fummo tutti denudati e depilati in ogni parte del corpo. Successivamente con delle macchinette come quelle con cui si dà l’insetticida fummo cosparsi con un liquido che sulla pelle irritata dai rasoi non affilati, e specialmente nelle parti più delicate, provocava sanguinamento e croste dolorose.
A tutti fu tolto tutto, orologi, anelli, perfino gli occhiali; a me non tolsero nulla perché non avevo più nulla, avevo venduto tutto nei precedenti campi di concentramento per prigionieri di guerra a Rodi e in Grecia.
A quel punto eravamo completamente spersonalizzati, il nostro nome non esisteva più, sostituito da un numero(8) che non si doveva e non si poteva dimenticare. Restammo nudi in quella baracca fino al giorno successivo. Di mangiare non se ne parlava nemmeno ed era già il sesto giorno che non ci davano nulla.
Passammo la notte in quello stanzone, nudi, accovacciati l’uno accanto all’altro per soffrire meno il freddo. La mattina successiva, dopo la notte al freddo, ebbe inizio la vestizione con stracci che non erano più i nostri vestiti; avevano le strisce verticali come tutti gli altri già internati nel campo. Era strano il fatto che al momento della consegna dei vestiti non si teneva alcun conto della taglia del destinatario, per cui si potevano vedere persone alte e grosse con pantaloni stretti, e viceversa persone piccole con vestiti molto larghi. Né si poteva pensare di fare a cambio, nei pantaloni a destra sotto la tasca e sulla giacca sotto il taschino era cucito un nastrino col numero assegnatoci e un triangolo rosso con sovraimpressa la sigla della nazionalità: “It”. Quindi scambiarsi i pantaloni o la giacca equivaleva a falsare la propria identità.
Va inoltre detto che alla vestizione non ci diedero di che vestirci in modo completo, solo un paio di pantaloni, una giacca, una camicia un berretto e un paio di zoccoli di legno come quelli olandesi. Il freddo si faceva già sentire e in particolare i piedi nudi dentro quegli zoccoli erano una sofferenza”. […]».
«La baracca, come tutte le altre, era costruita per contenere 100 prigionieri ma in pratica eravamo molti di più, certamente un migliaio. […]».
«L’ordine, la disciplina, la distribuzione del rancio, le punizioni, tutto era gestito da dei prigionieri scelti, i famigerati “Kapó”. È difficile poter descrivere la loro cattiveria e il loro livello di criminalità: picchiavano tutti in ogni momento, senza motivo. Potevano uccidere, e uccidevano, senza alcun riguardo vecchi e bambini. In parte erano tedeschi, delinquenti comuni, ergastolani; i non tedeschi erano polacchi, uomini spregevoli e cattivi nel più profondo della loro anima. All’interno delle baracche non vi era l’ombra di una sentinella tedesca. I Kapó vestivano degli stessi stracci nostri, ma puliti e adattati al loro fisico; non erano denutriti, mangiavano a sazietà prendendosi parte del nostro vitto e distribuendoci il resto di una razione già di per sé insufficiente. Neanche la voce avevano normale, ma per incutere maggior timore parlavano con toni alterati e gutturali. […]».
«Ecco ora come si svolgeva in generale la vita a Gross Rosen, il mio primo campo di prigionia.
Al mattino uscivamo fuori della baracca, in fila; dietro di noi c’era un militare “SS” che ci divideva: alcuni dovevano andare a destra, altri a sinistra. Quelli a sinistra erano messi a morte poco dopo, quelli a destra andavano a lavorare. I condannati a morte venivano indirizzati verso le camere a gas per essere eliminati. […]».
«Una volta, dopo una pioggia violenta, franò un argine argilloso del campo e così ci incolonnarono e ci portarono sul posto per rimuovere la terra; avevamo solo i badili per rimuovere la terra, ma nulla per portarla via, allora i kapó ci fecero indossare la giacca al contrario, con i bottoni dietro; prendendo con le mani il margine inferiore si formava una specie di grembiule in cui si poteva caricare una palata di terra. Una fila interminabile di prigionieri andava e veniva come schiavi delle epoche antiche. Tutto fra offese, percosse in ogni parte del corpo.
Il pomeriggio era dedicato all’appello nella grande piazza del campo, anche se non era un appello vero e proprio ma una “conta”, ed era una tragedia, perché il nostro nome non esisteva più, ma solo i pezzi “stir”. Piano piano tutte le baracche si svuotavano e in colonna percorrevamo la strada centrale, quella strada ordinata e pulita che mi aveva tanto fatto sperare al mio arrivo. Al comando del kapó dovevamo cadenzare il passo in tedesco: “ein – zwei – drei – vier – links – links!”. (Uno-due-tre-quattro-sinistra-sinistra). Al comando “links!” picchiavamo tutti forte il piede sinistro in terra con gli zoccoli. Si giungeva così alla grande piazza e ci volevano ore per allinearci tutti. […]».
«Quando tutto era pronto venivano le “SS” a contare: i “pezzi” in piazza, più quelli al crematorio, più quelli fuori per il lavoro dovevano dare la somma esatta e finché i conto non tornavano non si rientrava nelle baracche.
Non sempre era tempo buono, spesso pioveva e dovevamo prendercela tutta fino alle ossa; rientrando nella baracca non c’era il cambio asciutto ma tremanti e gocciolanti piano piano ci asciugavamo col calore del corpo.
Un giorno i kapó ci fecero uscire dalla baracca in un spazio fra la baracca e il muricciolo di sostegno del terrapieno. Dopo molta attesa venne una guardia “SS” con un foglio in mano e chiamava i prigionieri col numero. I polacchi, la quasi totalità dei prigionieri, capivano il tedesco; io invece non capivo una parola e quando il tedesco chiamò il mio numero non risposi. Lo chiamò per tre volte e vi fu silenzio.
Il tedesco andò in collera.
Il polacco che avevo accanto mi guardò il numero sul petto e mi fece capire che il chiamato ero io. Tardivamente risposi in italiano: – Presente! – Il tedesco con voce alterata e urlando mi chiamò davanti a sé e dai cenni lo capii. Mi misi sull’attenti: il dislivello del terreno faceva in modo che lui in piedi sul muretto di contenimento avesse i piedi all’altezza del mio torace. Dopo aver gridato con ira furibonda mi scagliò un calcio con la punta dello stivale in pieno petto. Io rotolai in terra fra le file dei prigionieri: mi sentivo morire dal dolore, credevo mi avesse sfondato il torace.
Ero smarrito, quel trattamento mi angosciava. Non riuscivo a capire il perché e quale potesse essere la forza di tanta cattiveria radicata in un animo umano, quale potesse esserne il motivo. Ero sconcertato e dei mille pensieri che mi venivano, nessuno approdava ad una qualche giustificazione.
In quei momenti di sconforto il buio si faceva luce nel perdono, nella preghiera e nella fede. Imploravo il Signore perché li perdonasse e avesse pietà di loro.
In quei giorni, nelle baracche, la morte era la nostra unica amica.
Al mattino molti non si alzavano; altri andavano alla latrina e lì restavano agonizzanti o morti nei loro stessi escrementi. I kapó addetti al recupero dei cadaveri lavoravano tutto il giorno. Li portavano ad un grosso mucchio nei pressi del “crematorium” e lì altri kapó pensavano al resto. Questo mucchio veniva alimentato anche da cadaveri provenienti probabilmente da altri campi che un grosso camion scaricava tutti i giorni. La ciminiera del “crematorium” fumava sempre, notte e giorno, e quando le giornate erano calme, l’aria pesante e il cielo plumbeo, il fumo non andava in alto ma ricadeva sul campo, orribile. […]».
«La permanenza a Gross Rosen per me non fu lunga ma fu sufficiente per imparare a non reagire mai alle percosse dei kapó: reagire significava essere uccisi.
Un giorno fummo trasferiti in un sottocampo a Breslao per lavorare in una fabbrica di carri armati. Il viaggio fu lungo, partimmo in treno su vagoni scoperti sotto la pioggia e la neve.
Nel nuovo campo trascorsi alcuni mesi; il trattamento non era diverso dal precedente e il tempo migliore erano le dodici ore giornaliere trascorse in fabbrica. […]».
«A giudicare dal freddo, penso di aver trascorso in quel campo gran parte dell’inverno. Non eravamo mai certi in quale giorno e in quale mese fossimo. Riuscivamo a renderci conto solo del giorno della settimana prendendo come riferimento la domenica perché solo in questo giorno, anche se non sempre, ci facevano fare la doccia e ci disinfettavano i vestiti per uccidere i pidocchi che erano un grande tormento. Dopo la disinfezione si stava bene per due o tre giorni, poi ritornavano a coprirci e a tormentarci. Basti dire che le cuciture, le asole e le pieghe dei vestiti erano bianche perché piene di uova dei pidocchi che vi si annidavano.
Anche se non tutte le domeniche, quando c’era, la disinfezione era una tragedia e molti, i più deboli, rendevano l’anima a Dio. I kapó entravano nelle baracche e, con i modi soliti, nudi, con i vestiti sotto il braccio ci facevano correre attraverso il piazzale centrale con la neve alta per circa 500 metri. Raggiungevamo la baracca dove si depositavano i vestiti per la disinfezione e poi sempre nudi di nuovo fuori verso la baracca delle docce. All’entrata un kapó ci versava in mano un cucchiaino di polvere bianca che era il sapone, ma era così poco che appena potevamo lavarci il viso. Spesso succedeva che nella confusione, per schivare le botte dei kapó, cadeva in terra e allora bisognava lavarsi solo con l’acqua.
Quello però non era un bagno, era una nuova tortura. Chi regolava l’erogazione dell’acqua era certamente un sadico criminale: all’acqua gelida faceva seguito quella bollente per tutto il tempo, fino a quando i kapó non decidevano di farci uscire. Alcuni non sopravvivevano. Nudi e bagnati si usciva dalle docce di nuovo nella baracca dei vestiti e sempre nudi e bagnati, attraverso il campo innevato, con temperature di 10 o 15 gradi sotto zero, ritornavamo alle baracche, sempre in meno di quando eravamo partiti. […]».
«Alle normali percosse dei kapó si dovevano aggiungere le sevizie straordinarie. Spesso ci svegliavano in piena notte, ci portavano fuori nudi e ci facevano rotolare nella neve fresca per una o due ore dando segno di benessere”. (Oltretutto, costretti a dare segno di benessere! – n.d.r.). […]».
Riferendomi ovviamente ancora alla testimonianza di Mauro Betti, sintetizzo quanto segue per brevità di esposizione: – Durante il percorso dalla fabbrica, a Breslao, verso il campo e viceversa i prigionieri lavoratori raccattavano frammenti di zoccolo di cavallo, unghia o callo, che un maniscalco, che si incontrava sul percorso, toglieva dallo zoccolo, appunto, per meglio poterne adattare il ferro.
Non era facile tuttavia vedere e impossessarsi di tali residui, dato che passavano davanti alla mascalcia durante le ore notturne.
Anche se un pur piccolo ritaglio, esso veniva succhiato con un gusto “come se fosse stato il giorno di Pasqua”.
Ma ora riprendo il suo dire:
«Il fatto che fosse buio era un vantaggio per i polacchi perché qualche volta qualcuno riusciva a scappare. Per questo la direzione del campo decise di farci dipingere sui vestiti con vernice bianca fosforescente una croce sul dorso della giacca e due strisce laterali lungo le braccia e i pantaloni. In questo modo le fughe diminuirono, anche perché chi veniva ripreso non aveva scampo, veniva impiccato nella piazza principale del campo di fronte a tutti e il corpo veniva lasciato appeso per giorni e giorni, a monito per tutti. Se invece il fuggitivo non veniva ripreso venivano puniti tutti gli altri in più modi, o non dandoci il rancio, o intensificando le percosse o facendoci alzare la notte e rotolarci nella neve come ho già descritto. […]».
«Arrivò il giorno in cui i tedeschi, con l’avanzata dei russi dovettero ritirarsi e noi con loro. Il cammino fu lungo e la sopravvivenza davvero un miracolo. La nostra meta fu Buchenwald. […]».
«Durante il viaggio non veniva distribuito il vitto. Alla partenza dal campo ci diedero uno di quei mattoni di pane dicendo che doveva bastare per tutto il viaggio. Tutti lo mangiammo subito.
Alla seconda notte di cammino attraversando una vasta pianura si abbatté su di noi una tempesta di pioggia, di neve e di vento, tanto forte che fummo abbandonati dalle guardie “SS”. Restammo soli e al buio in mezzo alla neve alta vagando per la pianura, tutti insieme, come un branco di pecore, stando ben accostati l’uno all’altro per scaldarci fra noi e darci almeno un po’ di benessere. Il vento forte soffiava sempre dalla stessa direzione e chi si trovava sul lato esposto fuggiva girando intorno al branco per raggiungere il lato riparato. Dopo un po’ uno si trovava al centro e, via via che la gente continuava a scappare verso il lato riparato, di nuovo dalla parte esposta per spostarsi di nuovo come prima. In questo modo il branco andava alla deriva per la pianura spostandosi continuamente. […]».
«Passata la tempesta le “SS” tornarono più feroci di prima e si resero conto che molti polacchi, cechi e russi erano scappati. Alcuni ci saranno riusciti, ma molti furono ripresi e fucilati subito. Il nostro numero si era ridotto del 50%, fummo presto inquadrati di nuovo e rimessi in cammino.
In quel giorno molti caddero sfiniti e quindi uccisi dal plotone “SS” che camminava in fondo alla colonna. I corpi restavano sul ciglio della strada e non so se qualche buona persona si sia preso la cura della loro sepoltura. […]».
«Dopo essere stati allineati per lungo tempo si presentò un ufficiale “SS” e ci passò in rivista, una rivista strana, perfida e mortale. Cominciò a contare i gruppi di cinque, al quinto gruppo i cinque uomini che lo componevano venivano fatti uscire. Ogni venticinque uomini ne venivano selezionati cinque, il 20% del totale.
Io e il mio amico Martino (prima ricordato, però in un capitolo da me omesso – n.d.r.), rimanemmo fra i vivi, quelli che dovevano morire furono fatti denudare davanti a noi, in fila indiana furono portati dietro il grande deposito e ad uno a uno varcarono la soglia che porta alla vita eterna. […]».
«Giunse il momento della partenza. Alcuni prigionieri avevano scavato nel grano dei cunicoli lunghi e ben nascosti per eludere la partenza ma le “SS” non si lasciavano ingannare perché conoscevano il numero esatto dei prigionieri rimasti. Grazie anche ai cani nessuno di loro sfuggì alla cattura e alla successiva eliminazione. Fummo avviati ad una stazione ferroviaria. Nonostante le eliminazioni eravamo ancora molti e completammo un trasporto di vagoni merci, scoperti. Eravamo cento prigionieri per ogni vagone, e al centro di ognuno, in uno spazio protetto dal filo spinato c’erano due sentinelle “SS”. Facevamo lunghe soste nelle stazioni ed eravamo sempre sotto la pioggia gelida o la neve. Lo spazio era insufficiente e non si poteva stare seduti, quindi eravamo tutti in piedi stretti uno accanto all’altro; questa condizione faceva molte vittime, ma egoisticamente creavano spazio: i corpi senza vita venivano stesi sul pavimento del vagone e venivano calpestati dai vivi. Più ne morivano più spazio si creava tanto che io e il mio amico Martino ci accorgemmo che un polacco accanto a noi stava morendo e ne approfittammo: lo facemmo accostare alla parete del vagone in modo che quando morì cadde disteso lungo di essa e su quel corpo potemmo stare seduti per il resto del viaggio.
La nostra sopravvivenza fu un miracolo. Arrivati a Buchenwald ci fecero scendere, ma prima di entrare al campo fummo costretti a scaricare i cadaveri. Li accatastavamo in terra davanti ad ogni vagone, i più erano morti nei propri escrementi.
Sono trascorsi più di cinquant’anni da questi fatti (il libro è del 1998 – n.d.r.) e questa è la prima volta che racconto anche questi particolari. Non l’ho mai fatto nemmeno nelle scuole quando periodicamente vado a testimoniare.
In quel campo entrammo la sera stessa e le condizioni e il trattamento non differivano dal primo campo di Gross Rosen, i kapó e le “SS” avevano il solito comportamento criminale. […]».
«La nostra condizione fisica era precaria, il nostro peso corporeo doveva essersi già molto ridotto, non posso dire di quanto perché non c’era possibilità di pesarci, ma lo stato di estrema magrezza di tutti era fin troppo evidente.
Fummo fortunati, il viaggio non fu lungo e quindi riuscimmo a sopravvivere e a giungere al campo di Flossenburg. […]».
«I campi di prigionia erano tutti simili fra loro e anche quello di Flossenburg non aveva nulla di diverso, stessa vita, stessi kapó, stesso vitto, stessa disciplina, stessi pidocchi. […]».
«Flossenburg è stato il mio ultimo campo. Era super affollato, la stragrande maggioranza erano polacchi di ogni età, vecchi, giovani e bambini. Poi c’era una piccola minoranza che rappresentava un po’ tutte le nazioni europee.
Lì ho avuto modo di incontrarmi con altri italiani: Santo Arlenghi di Vigevano; Eugenio Pertini di Genova, fratello di Sandro, poi Presidente della Repubblica; Danilo Panciatici, ebreo di Livorno, e tanti altri di cui non ricordo più il nome. So solo che di tutti loro solo io e Santo siamo tornati, e attualmente solo io vivo ancora.
Nel raccontare queste cose non posso non far menzione della crudeltà dei polacchi. Nonostante la convivenza non ho mai potuto allacciare rapporti di amicizia con nessuno di loro; li ho sempre trovati perfidi, cattivi e soprattutto spioni. Basti dire che i kapó non tedeschi erano tutti polacchi e nemmeno fra loro c’era rispetto; ho visto uccidere dai kapó polacchi a forza di botte dei loro concittadini, vecchi di settanta anni e bambini. Non si rispettavano nemmeno fra di loro ed erano veramente cattivi.
Ogni mattina ci portavano dal campo a rimuovere le macerie nelle città vicine bombardate, partivamo tutti dalle baracche senza subire selezione, questa avveniva durante il lavoro, chi non ce la faceva moriva da sé. Il lavoro si svolgeva sempre sotto le percosse dai kapó e calci delle “SS”.
Il freddo era sempre intenso. Una mattina fummo portati ad uno scalo ferroviario dove durante un bombardamento notturno era stata colpita una tradotta che trasportava vagoni carichi di bestiame. I tedeschi avevano portato via tutte le carni buone e lasciato sul terreno i visceri: fu una grande occasione e ci avventammo tutti su quei visceri strappandoceli fra di noi. In mezzo al tanfo spremevamo le budella del loro contenuto e poi con ancora molta merda all’interno le mangiavamo avidamente così com’erano sotto lo sguardo divertito delle “SS” che assistevano soddisfatte alla scena. […]».
«Una mattina ci fecero uscire dalla baracca, eravamo un migliaio, ci inquadrarono ma non ci portarono al lavoro come al solito; ci fecero entrare invece in un’altra baracca al cui interno c’erano delle docce. La cosa non ci dispiacque, perché con tutti i pidocchi che avevamo addosso un lavaggio anche di sola acqua non faceva male. Rimanemmo dentro quella baracca fino a sera, senza mangiare, stretti, tutti in piedi per mancanza di spazio. Mi raccomandavo a Martino, le sue condizioni fisiche erano migliori delle mie e avrebbe potuto aiutarmi. Non capivamo perché, se dovevamo fare la doccia, non ci avevano fatto togliere i vestiti, la nostra paura era che cominciassero a far scendere l’acqua senza che noi ci fossimo spogliati. Io stavo molto male, fui colpito da una forte crisi, credevo di morire e mi raccomandai a Martino di darne avviso ai miei genitori nel caso lui fosse sopravvissuto. Persi conoscenza e caddi ma non era la morte, fu solo uno svenimento: dopo poco mi rialzai con il conforto e l’aiuto del mio indimenticabile amico.
Giunse la sera. Un ordine superiore ci salvò. Ci fecero uscire e ritornare alle nostre baracche. In quella giornata di sofferenza la morte non ci volle: quelle docce, infatti, erano una camera a gas e noi avremmo dovuto essere uccisi tutti. Nessuno di noi era consapevole di dove eravamo stati, ce lo rendemmo conto solo dopo la liberazione. Nella baracca ci fu dato una fettina di pane tedesco, 30 o 40 grammi, con un pezzetto di margarina. Quello fu il nostro pasto. […]».
«In quei giorni me ne stavo silenzioso e assorto nei miei pensieri, solo, in un angolo della baracca, lontano il più possibile dai kapó. Si avvicinò a me un polacco, cosa molto strana, mai capitata prima. Ogni volta che avevo tentato di parlare con loro la risposta era stata sempre la solita: “kurwa jego mai”, la puttana di tua madre; fu quindi una cosa strana. Aveva qualcosa in mano, ne strappò un brandello e me lo offrì. Era carne cruda che lui stava mangiando, la presi e insieme a lui la divorai con avidità, senza starci troppo a pensare. Il polacco, senza una parola, si allontanò e si confuse con gli altri prigionieri. Dopo però cominciai a riflettere: perché aveva scelto proprio me e non qualcuno dei suoi amici connazionali per dividere una cosa così preziosa? Perché quella carne era cruda e non cotta? Dove mai aveva potuto trovare all’interno del campo una porzione di carne così grossa da poterne offrire anche a me? Perché aveva un colore rosato tenue e non intenso e scuro? Chi gliel’aveva data?
Fui assalito da pensieri atroci, cercai inutilmente il polacco per avere spiegazioni ma fu impossibile, era sparito tra i prigionieri e non potei più rivederlo.
Che cosa avevo potuto fare anche se innocentemente, preso dal solo desiderio di mangiare? Furono momenti terribili che io non so descrivere e che mi turbano tutt’ora nella mia coscienza di cattolico. […]».
Agghiacciante!
Preferisco far terminare così questo racconto, anche se, del caro Mauro Betti, ci sarebbero da riferire moltissimi altri fatti.
Al mio pur modesto mezzo affido perciò, a questo punto, pagine tuttavia ricche di parole, soprattutto, ovviamente quelle non mie; pagine, però, ricchissime di umani e retti significati. L’augurio è che le nuove generazioni possano trarne monito, non certamente perché esse ne abbiano colpa – come potrebbero! -, bensì per esortare loro medesimi e mettere in guardia a loro volta pure coloro che, nati e vissuti in democrazia, potrebbero non essere sufficientemente vaccinati; ossia non preparati abbastanza, proprio perché avvenimenti del genere sfiorano la mostruosità e potrebbero lasciare l’apparenza, ma soltanto quella, di vicende impossibili, irreali. Però tali atrocità sono purtroppo avvenute; e se certi eventi sono accaduti, potrebbero ripetersi, magari con altre sembianze, ma pur sempre della massima pericolosità.
Occorre quindi, appena se ne dovesse presentare malauguratamente l’evenienza, reprimere sùbito ogni benché minimo tentativo di strapotere: stroncarla alla radice, quindi.
In una mia lirica, citata da me più volte, nell’ottobre del 1978 (il libro è «Il Rifugio nell’Anima» e la lirica s’intitola “Scalfitture”) dicevo, non a caso:
“[…].
– Ma nessuno vuole la guerra -,
forse obietterai. Sì, certo,
ma sappi che comunque essa incalza:
la pace non è un bene stabile,
è conquista,
e quindi non puoi startene inerte.
Ogni sprazzo di odio,
ogni tentativo di inganno,
ogni atto di orgoglio
è un atto di guerra.
[…]”.
Ora, come più sopra anticipavo, dal citato opuscolo intitolato «Per non dimenticare», traggo l’intero capitolo relativo a “Le foibe: una strage negata per sessanta anni, su cui si comincia a fare luce”.
L’articolo si rifà a sua volta alla voce “foibe” curata dal Prof. Gianni Oliva in “Dizionario del fascismo”, ed. Einaudi.
Trascriverò tutto con massima cura; e anche in questo caso userò le virgolette, per voler significare che non ho alterato alcunché:
– «Nella prima definizione del vocabolario, “foiba” è soltanto un’espressione geografica e si ricollega a uno degli aspetti peculiari del paesaggio carsico: indica una fenditura, profonda anche molte decine di metri, che si apre sul fondo di una dolina(9) o di una depressione del terreno e che l’erosione millenaria delle acque ha scavato nella spugna della roccia in forme gigantesche e tortuose.
Nel linguaggio storico, le “foibe” si associano invece alle eliminazioni di italiani, nel settembre-ottobre 1943 e, soprattutto, agli eccidi di massa compiuti nella primavera del 1945 dall’esercito di liberazione iugoslavo del maresciallo Tito. In realtà, non tutte le vittime furono eliminate nelle foibe: molti morirono nei campi di deportazione slavi della Croazia o della Slovenia o durante le marce di trasferimento; alcune furono annegate nel mare Adriatico; altre occultate nelle cave di bauxite dell’Istria, altre ancora abbandonate nel luogo stesso dell’uccisione. Per la sua tremenda forza evocativa, il termine foibe è tuttavia entrato nel linguaggio comune per indicare l’insieme del fenomeno: rinvia al totale ribaltamento di valori implicito nell’idea di esseri umani fatti scomparire nelle viscere della terra alla stregua di rifiuti.
La prima ondata persecutoria risale alle settimane successive all’armistizio dell’8 settembre 1943 ed è localizzata nell’Istria. Di fronte al traumatico sgretolarsi della presenza militare italiana, le truppe militari della Wehrmacht occuparono le città portuali di Fiume e Pola, ma lasciarono temporaneamente libero il resto della penisola. In questo vuoto di potere, dominato dalla confusione e dall’incertezza, si inserirono due diverse dinamiche: da una parte, l’intervento organizzato delle formazioni partigiane slave operanti nella Lika e nel Gorskj Kotar – le regioni situate appena oltre il vecchio confine – che assunsero il potere civile “in nome del popolo”; dall’altra parte, l’insurrezione spontanea dei contadini croati, che diedero vita ad una vera e propria jacquerie(10), con l’incendio dei catasti e degli archivi comunali. In tale contesto, centinaia di cittadini italiani vennero catturati, rinchiusi in improvvisati campi di concentramento, sottoposti a sevizie, poi uccisi e gettati nelle foibe; in alcuni casi, le vittime furono gettate nel terreno ancora vive ed andarono incontro ad una terribile agonia.
Si trattava di una caccia indiscriminata contro chiunque fosse ricollegabile all’amministrazione italiana, entro un clima torbido nel quale il giustizialismo politico del movimento partigiano iugoslavo si mescolava con la violenza selvaggia della rivolta contadina: caddero quadri del partito fascista, possidenti con i loro familiari, rappresentanti della passata amministrazione, dai podestà ai messi comunali, dai carabinieri alle guardie campestri. La logica crudele che soprassedette alla persecuzione e alla morte degli infoibati ebbe caratteri al tempo stesso nazionali e sociali: si colpiva chi veniva percepito come italiano, come fascista o come possidente, in una confusione di ruoli che nell’immaginario collettivo della rivolta si sovrapposero l’uno all’altro.
Le spiegazioni del fenomeno sono complesse e rinviano alla storia della regione nella prima metà del XX secolo. Anzitutto alla politica del fascismo, che tra il 1919 e il 1922 si era caratterizzato nella Venezia Giulia per la sua aggressività antislava, assumendo i tratti ruvidi del “fascismo di frontiera”: come dimostrò l’incendio dell’Hotel Balkan di Trieste, sede delle associazioni slovene della città, nel luglio del 1920. Quando giunse al potere, Mussolini attuò in questa regione multietnica la politica dell’”assimilazione” nei confronti della popolazione slava, definita “allogena(11)”. Dalla riforma Gentile che vietava l’insegnamento in lingua straniera entro i confini del regno, al decreto del 1929 relativo all’italianizzazione dei cognomi, alla chiusura dei circoli ricreativi e culturali croati e sloveni, alle condanne inflitte dal Tribunale speciale, tutto il Ventennio fu caratterizzato da una politica di snazionalizzazione che colpì la comunità slava negandone l’identità politica e culturale. Il dato politico si intrecciò con quello economico: l’annessione all’Italia significò per l’Istria un arretramento della propria economia agricola, indebolita dalla concorrenza delle più fertili campagne venete e friulane; molte piccole e medie proprietà andarono in crisi, con le terre messe all’incanto e acquistate dai “regnicoli”. La situazione di avversione sorda, creata dopo il 1922, maturò nel corso del secondo conflitto mondiale, quando le forze italo-tedesche invasero la Jugoslavia sottoponendola a regime occupazionale. In tutta l’area si sviluppò un movimento di liberazione, guidato dal partito comunista di Tito, ma con una forte presenza nazionalista: quest’ultima fu tanto più significativa in Slovenia e nell’Istria per i contrasti sedimentati dal fascismo. L’eliminazione degli italiani coinvolti a vario titolo nella passata amministrazione divenne l’obiettivo di un progetto di “pulizia etnico-politica” nel quale l’avversione per l’etnia dominatrice si saldava all’ambizione di annettere alla nuova Jugoslavia le terre mistilingue. Il cruento passaggio di poteri dell’autunno 1943 fu lo sfondo in cui le diverse dinamiche sprigionarono la loro traumatica violenza, che si concluse all’inizio di ottobre quando l’offensiva scatenata dai reparti della Wehrmacht costrinse i partigiani croati e sloveni alla ritirata. Le vittime di questa prima ondata persecutoria sono quantificabili in circa un migliaio.
Nei mesi successivi, la situazione nell’area nord-orientale dell’Italia si fece esplosiva. Il movimento partigiano di Tito, ormai riconosciuto dagli Alleati come unico riferimento della lotta antitedesca in Jugoslavia, precisò la propria politica espansionistica, che voleva fissare il confine sulla linea dell’Isonzo. Gli obiettivi erano chiari: giungere per primi a Trieste e Gorizia, mirare al momento insurrezionale per estendere alle città e alla fascia costiera il controllo che le forze partigiane già esercitavano all’interno, insediare dovunque autorità amministrative slave: “diventerà nostro tutto ciò che si troverà nelle mani del nostro esercito”, affermò il più stretto collaboratore di Tito, Edvard Kardelij, riecheggiando Stalin. Da queste premesse discesero sia la strategia militare jugoslava della primavera 1945, che concentrò lo sforzo offensivo verso Trieste rinviando la liberazione di terre interamente slave come Lubiana, sia – soprattutto – la strategia politica. Perché la futura conferenza di pace riconoscesse l’annessione alla nuova Jugoslavia delle regioni mistilingue, era necessario che nessuno ne difendesse l’italianità, che la Venezia Giulia risultasse pacificata nel segno della rivoluzione sociale e sotto la bandiera jugoslava: per questo il gruppo dirigente nazionalcomunista di Tito predispose un piano per l’eliminazione di tutti coloro che potevano rappresentare un riferimento per la comunità italiana, fossero essi collaboratori del nazismo ed esponenti della Repubblica sociale, oppure sinceri militanti antifascisti, membri del Comitato di Liberazione Nazionale, partigiani comunisti contrari all’annessione, figure locali significative. Pulizia etnico-politica, dunque, da affidare all’Ozna (la polizia politica titoista) e ai reparti dell’esercito di liberazione, e da perseguire con la massima rapidità.
La vasta eco data dalla propaganda della Repubblica sociale alle foibe istriane dell’autunno del 1943, e la consapevolezza dei progetti espansionistici jugoslavi crearono forti tensioni all’interno del fonte resistenziale italiano della Venezia Giulia. Erano attive nella regione due formazioni maggiori, la brigata Osoppo, a prevalenza cattolica con una componente del partito d’azione, e la divisione garibaldina Natisone. I tentativi di creare un comando unificato si scontrarono con le prospettive di lungo termine: i garibaldini sembrarono avallare le aspirazioni annessionistiche di Tito, tanto che nel 1944 si trasferirono a est dell’Isonzo, passando alle dipendenze del IX corpus sloveno; le formazioni osovane si posero il problema opposto, di arginare l’avanzata jugoslava, mentre nei Cln locali si rafforzarono le ali più intransigenti sul piano nazionale. Ad alimentare il clima di divisione intervenne poi Palmiro Togliatti, che inserì la questione del confine nord-orientale in una prospettiva internazionalistica: nell’autunno del 1944 egli inviò al partito comunista di Trieste una direttiva in cui invitava alla più stretta collaborazione con il movimento partigiano jugoslavo, affermando che “l’occupazione della regione giuliana da parte delle truppe del maresciallo Tito” significava che in quelle terre “non vi sarà né un’occupazione inglese, né una restaurazione dell’amministrazione reazionaria italiana”.
Il dissidio fra la componente moderata e la componente comunista del fronte resistenziale giuliano – di cui l’eccidio delle malghe sul Porzus, nel febbraio del 1945, fu l’episodio più drammatico – indusse gli angloamericani a non affrettare l’avanzata verso nord-est, nel timore di trovarsi in una guerra civile come era già accaduto in Grecia. Questo permise all’esercito di Tito di vincere la “corsa per Trieste”: il 30 aprile i primi reparti jugoslavi entrarono nella città, insediarono le proprie autorità amministrative ed iniziarono il previsto programma di eliminazione etnico-politica. Nel periodo compreso fra l’inizio di maggio ed il 9 giugno, quando gli accordi internazionali concordati tra angloamericani e sovietici portarono alla definizione del confine sulla cosiddetta linea Morgan, migliaia di italiani vennero prelevati dalle proprie case e fatti scomparire, infoibati o trascinati nei campi di deportazione slavi. Il numero delle vittime è stato oggetto nel corso degli anni di polemica tra chi ha minimizzato e chi ha sovradimensionato: allo stato attuale delle ricerche, la stima di circa 10.000 persone eliminate va considerata la più attendibile, ed è comunque tale da inquadrare il fenomeno entro le reali dimensioni di un eccidio di massa. Subito dopo la fine della guerra, sui morti giuliani, istriani e dalmati è calato un triplice silenzio. In primo luogo, si è trattato di un silenzio internazionale: quando nel 1948 si consumò la rottura fra Stalin e Tito, e i comunisti jugoslavi vennero condannati da Mosca come “deviazionisti”, l’Occidente prese a guardare al governo di Belgrado come ad un interlocutore prezioso, sicché venne meno l’interesse a fare chiarezza sulle migliaia di italiani scomparsi nella primavera del 1945. In secondo luogo si è trattato di un silenzio di partito: il Pci non aveva alcun interesse a tornare su una questione che evidenziava le contraddizioni tra la sua nuova collocazione come partito nazionale e la sua vocazione internazionalista, e che rinviava alla responsabilità di Togliatti sul problema del confine nord-orientale. In terzo luogo, si è trattato di un silenzio di Stato: per Alcide De Gasperi e i governi centristi, rimuovere il problema triestino significava evitare un argomento destabilizzante, che rivelava la debolezza della dirigenza politica italiana in sede internazionale e i cedimenti al tavolo della conferenza di pace. Entro un tale quadro, reso più drammatico dall’esodo istriano e dalmata e dal senso di sconfitta veicolato da centinaia di migliaia di profughi costretti ad abbandonare le loro case e le loro attività, il silenzio apparve a molti come la risposta più facile ed immediata. Per ragioni diverse nelle premesse, ma convergenti nel risultato, l’umana volontà di sapere fu sacrificata all’opportunità politica di tacere. Le foibe si sono trasformate così in una “strage negata”: oggetto di una memoria lacerata e contrapposta nella Venezia Giulia, ma in gran parte ignorata nel resto d’Italia».
Dalla più sopra citata pubblicazione del Comune di Castelfranco di Sotto, ritengo di trarre ancora diversi particolari, limitandone le righe per la ragione già espressa, e della cui operazione mi scuso ancora.
Dal cenno sulla storia dei campi di concentramento riporto i seguenti capoversi:
«[…] A Dachau venivano addestrate le SS che sorvegliavano i campi; qui fu sperimentato un regolamento, che venne poi progressivamente esteso, che regolava gli orari, le punizioni, l’applicazione della pena capitale. Da un punto di vista meramente numerico i prigionieri politici rinchiusi nei KL (Konzentrationslager – n.d.r.) diminuirono considerevolmente: la battaglia contro l’opposizione politica poteva ritenersi conclusa. Ma il nazismo si prefigurava di modificare la società tedesca: chiunque per motivi biologico-razziali non era considerato parte integrante della Volksgemeinschaft non era considerato un cittadino tedesco a tutti gli effetti. Il progetto di purificare l’intera società portò alla persecuzione di una nutrita categoria di persone: gli ebrei, gli “asociali”, gli zingari, i vagabondi, i renitenti al lavoro, i testimoni di Geova, gli omosessuali, i criminali comuni. Il 25 gennaio del 1938 fu emanato un nuovo decreto che rinforzava l’istituto della detenzione preventiva, seguirono nuove ondate di arresti, rivolte a portare nei KL soprattutto tutte quelle persone che vivevano ai margini della nuova società forgiata dal nazismo. […]. Allo scoppio della guerra la popolazione dei Lager era complessivamente di circa 24000 prigionieri, ma essa aumentò subito con l’ingrasso nei campi dei prigionieri provenienti dalla Polonia e in seguito dall’Unione Sovietica.
Con la guerra i campi subirono altre profonde trasformazioni: innanzi tutto la popolazione dei KL andò sempre più internazionalizzandosi: i primi stranieri a entrare nei lager furono i polacchi, poi i sovietici, gli spagnoli, i francesi, gli olandesi, nel 1943 gli italiani, nel 1944 gli ungheresi. Si trattava di resistenti, di oppositori politici ma anche di cittadini rastrellati un po’ ovunque in Europa e costretti a lavorare come schiavi nelle industrie tedesche. Sorsero nuovi grandi campi in Polonia, tra cui Auschwitz nel 1940 e Gross-Rosen, nell’alta Slesia, e Natzweiler in Alsazia. […]. Durante la guerra si accentuò, fino ad arrivare allo sterminio, la persecuzione degli ebrei. La strada per arrivare a Auschwitz e alle camere a gas fu tortuosa: dapprima furono creati in tutta l’Europa orientale i ghetti, in cui furono concentrati in condizioni spaventose gli ebrei, poi a partire dall’agosto 1941 in Unione Sovietica le Einsatztruppen, che seguivano nelle retrovie l’avanzata dell’esercito tedesco, iniziarono i massacri indiscriminati di donne, uomini, bambini. Lo scenario dei massacri era molto simile: uomini, donne, vecchi e bambini venivano fatti uscire dalle loro case e giunti in luoghi defilati rispetto ai villaggi o alle città venivano costretti a scavare enormi fosse comuni e qui uccisi mediante fucilazione. Si calcola che siano stati eliminati in questo modo circa un milione e mezzo di ebrei. […]. A partire della fine del 1944 i nazisti iniziarono a evacuare i campi posti più a est, ebbero così inizio le micidiali marce della morte che provocarono migliaia di vittime. […]. Varcare la soglia del lager significava per il prigioniero abbandonare la vita precedente e attraverso una serie di azioni simili a un rito di passaggio, egli entrava a far parte della popolazione senza nome del campo. In tutti i campi la procedura di arrivo era identica: i prigionieri dovevano spogliarsi completamente, abbandonare i loro vestiti e tutto quello che avevano con sé. Quindi completamente nudi venivano rasati, sottoposti alla doccia che era sempre o caldissima o freddissima, infine ricevevano la divisa dei prigionieri e in questo modo entravano a far parte della popolazione del campo. Questa procedura era spesso accompagnata da bastonate e violenze che servivano a disorientare ancora di più il prigioniero. L’ultima fase del processo di iniziazione consisteva nella registrazione del prigioniero che perdeva la sua identità e il suo nome per diventare un numero: esso testimoniava la trasformazione dell’individuo in uomo massa, la metamorfosi della società degli individui nella società seriale dei senza-nome. Dopo la registrazione il prigioniero veniva assegnato a una baracca. I prigionieri avevano pochissimo tempo per abituarsi alla vita del Lager: se volevano sopravvivere dovevano capire in fretta le regole della sopravvivenza. Le baracche offrivano al detenuto uno spazio minimo e soprattutto nella fase iniziale i prigionieri erano costretti a dormire in uno stesso pagliericcio in due o anche in tre. Una tale mancanza di spazio generava spesso lotte e liti furibonde. La sveglia era alle 4 o alle 4,30 del mattino (d’inverno un’ora più tardi). […].
All’interno della popolazione del lager erano presenti essenzialmente due classi: quella dei cosiddetti prominenti, che a loro volta costituivano una complessa gerarchia, e quella della massa dei prigionieri che lottavano ogni giorno per sopravvivere. L’appartenenza alla classe nobile del campo dipendeva anche dalla classificazione di ciascun prigioniero. Infatti fin dal 1936 le SS introdussero i triangoli che distinguevano le varie categorie di prigionieri: verde per i criminali, nero per gli “asociali”, grigio e poi nero per gli zingari, rosso per i politici, giallo per gli ebrei. […].
Punizioni e morte – Nei lager era in vigore un regolamento, composto nel 1933 da Eicke e poi progressivamente esteso a tutti i campi. Le punizioni erano del tutto arbitrarie e servivano solo a mantenere il terrore fra i detenuti. Inoltre spesso venivano emanate norme contraddittorie, oppure venivano fatte richieste impossibili, al solo scopo di poter esercitare un potere vessatorio nei confronti dei prigionieri. Essi, se volevano sopravvivere, dovevano cercare di rendersi il più possibile invisibili. Le punizioni venivano spesso eseguite sul posto ed erano i sorveglianti o i Kapos a infliggerle, ossia erano prigionieri che infierivano su altri prigionieri. Il ricorso alla delega di poteri dalle SS ad alcuni prigionieri si mantenne costante sostanzialmente fino alla fine: è difficile immaginare un potere più grande di quello che riesce a fare delle proprie vittime i carnefici di se stesse. […]».
Per la chiusura di questo capitolo, che avrebbe dovuto essere assai più lungo per poter dire molte altre cose; per poter riferire le molte altre ignominie perpetrate da quella imbarbarita e indescrivibile gentaglia, anziché scrivere un capitolo avrei dovuto scrivere un libro. Spero tuttavia che a chi, un giorno, forse capiterà di leggere questo mio accorato scritto, un’idea abbastanza approssimativa possa farsela. Fortunatamente, almeno i popoli d’Europa in cui anche noi italiani viviamo, sembrano avere trovato la strada della non belligeranza, se non quella di una vera e propria amicizia: non si può certo pretendere tutto e sùbito, ma mi auguro che ce la faremo. L’importante è la volontà di rispettare le Leggi, che sono state stabilite da gente benpensante venuta prima di noi.
Mi auguro che sia rispettata la Costituzione Italiana (a detta di esperti, una delle migliori in ambito internazionale) come mi auguro che ci si attenga alla Dichiarazione Universale dei diritti Umani (il cui testo integrale si trova, non a caso, pure nel citato opuscolo del Comune di Castelfranco di Sotto).
Qui, della Dichiarazione Universale, trascriverò solo due articoli. Sarebbe stato sufficiente che quei sanguinari del XX secolo avessero letto e seguìto soltanto il primo e l’ultimo articolo, dei trenta che la compongono, e tante mostruosità non avrebbero avuto luogo:
– Articolo 1: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.
[…].– Articolo 30: “Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati”.
Hanno fatto invece l’esatto contrario!
Empoli (FI), domenica 10 febbraio 2008
TOMMASO MAZZONI . PROPRIETÀ RISERVATA.
pubblicata su gentile concessione dell’autore.
NOTE E RIFERIMENTI:
(*) – (Acquisizioni dell’a. successive alla stesura del presente capitolo).
(1) – La mia forte emozione – Al racconto dei fatti occorsi all’ex deportato Mauro Betti era presente anche il Sindaco di Capraia e Limite Dottor Enrico Sostegni. Al medesimo Dottor Sostegni, dopo che l’importante evento era concluso, ho tentato di esprimere alcune parole, allo scopo di complimentarmi con lui e con tutta l’Amministrazione comunale per avere organizzato un così importante evento (e per tanti altri di cui sono a conoscenza). Non ci sono però riuscito: gli ho solo borbottando qualcosa, tanta era la mia commozione, senza dirgli ciò che intendevo dire. Ha però còlto il mio stato d’animo; anzi, potrebbe esserne perfino buon testimone. Ma, naturalmente, non occorrono certo conferme, di una siffatta circostanza: un pochino, ormai, mi conoscete.
(2) – In taluna di queste mie pagine – Tutto quanto mi raccontò Saffo Morelli è riportato al capitolo, intitolato certo non a caso “Arbeit macht frei” (Il lavoro rende liberi), che rivela tutta quanta la perfida ironia nazista.
Il libro nel quale parlo di Saffo Morelli è intitolato «Qualche tentativo» e, della raccolta di libri da me pubblicati, è il quinto della serie.
(3) – Le folli deportazioni nazi-fasciste – Il “Gran Consiglio del Fascismo”, il 6 Ottobre 1938, emise la “Dichiarazione sulla Razza”, uno dei principali documenti che costituirono il complesso delle leggi razziali promulgate dal fascismo, poi man mano perfezionate nella loro scellerata finalità. Ma fin già dopo l’entrata in vigore, nel 1937, del regio decreto legge n. 880 era stato vietato il “madamismo”, ovvero l’acquisto di una concubina, come pure il matrimonio di italiani con “sudditi delle colonie africane”. Il parlamento italiano promulgò poi altre leggi di marcato contenuto razzistico.
(4) – Un’accurata pubblicazione – È infatti stata realizzata a cura e per le personali ricerche dell’Assessore alla Cultura Cristian Pardossi del Comune di Castelfranco di Sotto (PI).
(5) – «Per non dimenticare» – Trattasi di una pubblicazione redatta dall’Ufficio Cultura del Comune di Castelfranco di Sotto (PI), sponsorizzata dal Comune stesso, da CARISMI e da Castelfranco Eventi Culturali.
(6) – Illumini i posteri – Oltre ad una prefazione dello stesso Mauro Betti, il libro presenta pure pagine del Sindaco Dottor Paolo Vanni, di Giovanni Parenti e di Sandro Betti. Vi è riportata anche una citazione di Primo Levi (1919-1987), pure deportato in un campo di sterminio: quello di Auschwitz. Segnalo a questo proposito anche la testimonianza di Primo Levi – per quei pochissimi che non lo avessero sentito nominare -, che pubblicò in un libro intitolato «Se questo è un uomo». Vi anticipo soltanto, per chi non l’avesse ancora letto e meditato, che Primo Levi così si è espresso, al fine di sensibilizzare tutti noi, con questo suo monito, per mezzo di queste sue tristi parole:
Voi che vivete sicuri
nelle vostre tiepide case,
voi che trovate, tornando a sera,
cibo caldo e visi amici.
Considerate se questo è un uomo
che lavora nel fango
che non conosce pace
che lotta per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna,
senza capelli e senza nome
senza più forza di ricordare
vuoti gli occhi e freddo il grembo
come una rana d’inverno.
Meditate che questo è stato:
vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
stando in casa, andando per via,
coricandovi, alzandovi,
ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
la malattia vi impedisca,
i vostri nati torcano il viso da voi(12).
(7) – Per la dedica che ha voluto apporvi: “Al Sig. Tommaso Mazzoni con grande stima e simpatia. Mauro Betti”.
(8) – Sostituito da un numero – Per l’esattezza, a Gross-Rosen (oggi Rogoźnica, in Polonia) il numero assegnato a Mauro Betti era KZ 63413; al campo di Flossenbürg (pressi del confine cecoslovacco), KZ 48236.
KZ significava Konzentrationslager, e non necessita di traduzione!
(9) – Dolina – Cavità a forma d’imbuto, con pareti variamente ripide, causata dall’erosione di rocce calcaree per l’effetto delle acque, con modalità diverse.
(10) – Jacquerie – Insurrezione contadina spontanea. Prende il nome dall’espressione canzonatoria di “Jacques bonhomme”, appellativo con il quale i proprietari terrieri si rivolgevano ai contadini. Detto nome deriva a sua volta da “jacque”, una giubba di ferro rinforzato che portavano i villani. Emblematicamente, ci si riferisce in particolare alla rivolta del maggio-giugno 1358 capeggiata da Guillame Carle. La rivolta durò una quindicina di giorni.
(11) – Popolazione slava, definita “allogena” – In uno Stato, la popolazione allogena è formata da cittadini di etnia diversa dalla maggioranza della popolazione; mantiene le proprie caratteristiche e l’autonomia culturale.
(12) – Primo Levi (1919-1987), da «Se questo è un uomo», scritto da dicembre 1943 a gennaio 1945. De Silva Editore (poi anche Einaudi Editore).



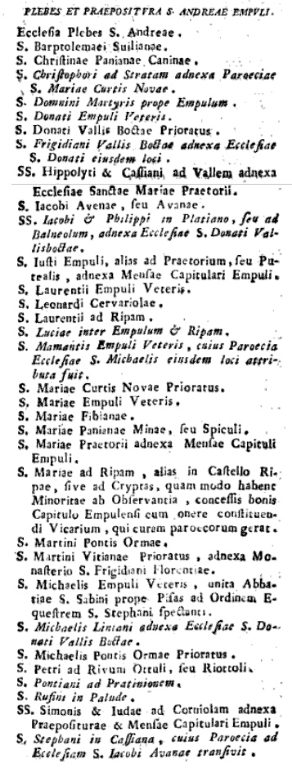
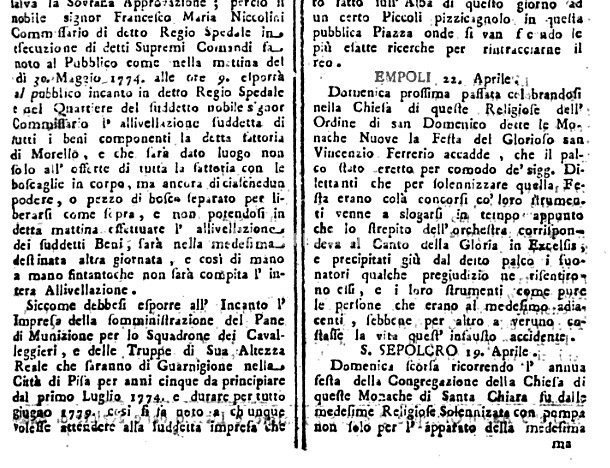
Questo articolo ha 0 commenti