Sab 05 Novembre 12.00 - Inaugurazione per il restauro dell’antico portone di Palazzo Pretorio del…
La donna gravida a Monterappoli era libera – di Paolo Santini
La donna gravida a Monterappoli era libera – di Paolo Santini
«Che alla donna gravida sia lecito tòrre delle frutte. Item providono et deliberarono, che a ciascuna donna gravida le sia lecito potere ire ne’ luoghi et possessioni altrui e tòrre delle frutte et cose, delle quali le venisse volontà, senza niuna pena». La rubrica 91, l’ultima, degli Statuti medievali di Monterappoli, è davvero straordinaria, oltreché piuttosto rara nel panorama degli statuti comunali comitatini. Allora – quanto sono cambiati in tempi !- il desiderio della donna incinta poteva nascere dal vedere e dal non poter mangiare un bel frutto maturo in un campo, e siccome il nascituro di qualsiasi condizione non doveva venire al mondo con qualche “voglia”, – credenza popolare sopravvissuta fino a qualche anno fa – ecco che la disposizione inserita all’ultimo tuffo nella silloge statutaria monterappolese veniva a colmare questa importante necessità, derogando oltretutto alla rubrica 30 dello stesso statuto che stabiliva che “nessuna persona potesse entrare senza espressa licenza del padrone nelle altrui possessioni” né tantomeno raccogliere frutti senza incorrere in una pesante sanzione. E allora, come negare la veridicità della ricorrente affermazione secondo la quale «la vita quotidiana nel Medioevo si trova soprattutto negli statuti»? Ma andiamo per ordine. Con il termine statuto nell’”età di mezzo” si designa un complesso organico di norme fondamentali per l’organizzazione ed il funzionamento di un ente, di solito elaborato dai rappresentanti dell’ente stesso, talvolta imposto per ordine di un’autorità superiore. Gli statuti dei comuni rurali costituiscono oggi una fonte straordinaria per la ricostruzione dello stato dei luoghi dal punto di vista urbanistico, toponomastico, delle abitudini e delle attività quotidiane. Il 24 gennaio del 1395 gli statutari Francesco di Tommaso, Nicoletto di Ruffino, Ghermondo di Cesare e Bertuccio di Fredi, tutti di Monterappoli, incaricati con apposito provvedimento di redigere il testo, espletate le necessarie formalità, consegnarono lo statuto per l’approvazione definitiva, che doveva avvenire naturalmente a Firenze. Gli approvatori fiorentini però erano inflessibili e cassavano le disposizioni ritenute lesive degli interessi della dominante, ma anche quelle che in qualche modo potessero andare contro le tradizioni. È il caso della rubrica 15, che si intitolava “Di non fare ardere facelline la sera di carnasciale”; gli statutari avevano inserito questa rubrica per impedire l’uso che allora vigeva di bruciare, durante la baldoria della sera di carnevale appunto, fusti di legno resinoso o altra legna, con grave danno economico per il comune e per le famiglie. La cassazione della rubrica permise dunque di far continuare anche a Monterappoli questo atavico uso. La compilazione monterappolese fa parte comunque di una singolare stagione di elaborazione normativa, incentrata prevalentemente sulle modalità di accesso alle cariche pubbliche. Queste elaborazioni statutarie, contemporanee all’istituzione capillare dei podestà e dei vicari nei principali centri del dominio fiorentino, rientravano in un preciso progetto generale di armonizzazione delle varie entità politiche presenti nel dominio stesso in una realtà statale più omogenea. Anche Monterappoli divenne dunque sede di podesteria, sebbene di quarto grado (infimo), con un ufficiale fiorentino che amministrava principalmente la giustizia civile ma nel contempo rappresentava gli interessi politici ed economici della dominante in loco. Tutto il contado (il territorio di pertinenza diretta della città gigliata) ormai si avviava ad essere scrupolosamente controllato attraverso una maglia strettissima di giusdicenti itineranti saldamente in contatto con le istituzioni centrali. Alcune norme statutarie possono sembrare oggi curiose, pur risultando invece fra le più significative e sollecitate dal popolo per gli usi di quel tempo; ad esempio il divieto minuziosamente codificato di “pigliare o saettare o uccidere alcuno colombo domestico d’alcuna colombaia d’alcuno del detto comune o d’altronde, alla pena di soldi quaranta per ciascun colombo”. I colombi all’epoca costituivano una preziosa fonte di reddito – oltre alle carni prelibate, ricercatissimo era il guano, fertilizzante straordinario – per coloro che li allevavano, di solito nelle colombaie, luoghi protetti da animali e da intrusi di ogni genere.
Paolo Santini




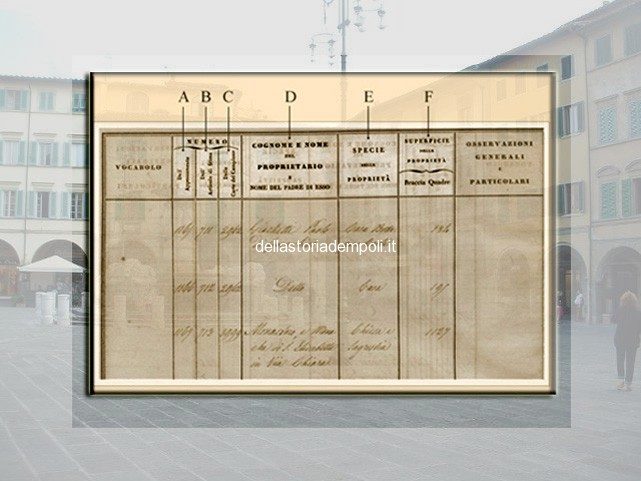
Questo articolo ha 0 commenti